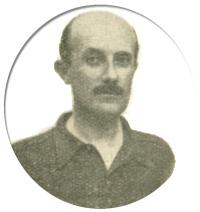Felice Balbo di Vinadio, discendente diretto di Cesare Balbo, nacque a Torino il 1° gennaio 1913. Al Liceo-Ginnasio D’Azeglio fu allievo di Augusto Monti, come Pavese, Mila, Bobbio. Come Bobbio si laureò sotto la guida di Gioele Solari, in giurisprudenza, presentando una tesi di filosofia del diritto su “Diritto e linguaggio”. Partecipò alla II Guerra Mondiale come sottufficiale tra gli alpini sciatori e ne riportò una salute indebolita. Nel 1941 iniziò a lavorare per la casa editrice Einaudi, dove conobbe Cesare Pavese e Giaime Pintor. Con Pintor si trasferì a Roma e prese parte al movimento antifascista. Fu tra gli artefici, insieme a Rodano, D’Amico, Ossicini, Sebregondi, Motta, Barca, Tatò e altri, del Movimento dei Cattolici comunisti, del Movimento dei Lavoratori cristiani e della breve vita del Partito della Sinistra cristiana, sciolto nel 1945. In quell’anno Balbo si iscrisse al Partito Comunista, rinnovando la tessera fino al 1950. Dal 1945 al 1950 fu a Torino, dirigendo insieme a Bobbio la “Biblioteca di cultura filosofica” di Einaudi. Partecipò alla fondazione delle riviste “Terza generazione”, insieme a Scassellati, Ciccardini, Motta, Sobrero, Pavese, e “Cultura e Realtà”. Tornato a Roma nel 1950, ottenne la libera docenza di filosofia morale nella Facoltà di magistero (1956). Già nel 1953 aveva firmato insieme ad altri una dichiarazione pubblica di obbedienza alla Chiesa cattolica. Entrò all’IRI alla fine degli anni ’50 per occuparsi della formazione dei quadri dirigenti, diventando direttore del Centro per lo studio delle funzioni direttive aziendali. Morì il 3 febbraio 1964. Noto per essere stato uno dei teorici del cattolicesimo comunista, Felice Balbo ebbe una formazione e dei riferimenti lontani dall’immanentismo della ‘ragione laica e progressiva’. Il suo interesse per il marxismo fu sempre interno a una filosofia dell’essere, per la quale l’ordine del mondo non è costruito ma ci è dato. Il problema cui Balbo rispose fu quello dell’aristotelismo tomista di fronte alla modernità: si trattava di mostrare che la filosofia dell’essere non costituisce un sistema rigido di formule che la condanna al passato, ma può rendere ragione del movimento e della vita storica. Perciò i compagni di strada con cui Balbo dialoga, pur nella diversità, sono soprattutto Mazzantini e Del Noce. Nella problematica che condivide con essi, Balbo crede di poter trovare l’aggancio storico e dinamico dei princìpi intelligibili dell’essere non già nella nozione di virtualità (Mazzantini), né mostrando come la filosofia dell’essere sia in grado di ‘comprendere’ la storia (Del Noce), bensì nel marxismo, maestro dell’efficacia storica del pensiero. Marx insegna che il pensiero è prassi, è un lavoro, una produzione che ha un’efficacia sulle cose, come una macchina. L’errore di Marx consiste nel trasformare la traduzione del pensiero nella prassi in una riduzione totale: perciò la prassi storica del marxismo è divenuta dogmatica – una formula da applicare solamente, non essendovi spazio per un margine critico che trascenda la prassi. Quel margine critico è invece offerto dall’ordine dell’essere, che appella la nostra prassi: esso è infatti il termine di realizzazione, l’ordine delle cose nel quale ci inseriamo con il lavoro. L’interesse di Balbo per Marx è stato metafisico, non politico. La questione del lavoro non riduce l’uomo all’insieme dei rapporti di produzione, come premessa al superamento rivoluzionario dell’alienazione. La centralità della questione del lavoro è per Balbo la centralità metafisica della collocazione del singolo nell’ordine dell’essere, per l’integrazione e la solidarietà. La concretezza marxista del lavoro è ‘compresa’ dalla metafisica tomista dell’esistenza. Le opere pubblicate da Balbo sono L’uomo senza miti (1945); Il laboratorio dell’uomo (1946); Idee per una filosofia dello sviluppo umano (1962); è postumo Essere e progresso (1966), compreso nella raccolta pressoché completa degli scritti: Opere 1945-1964. E’ stato pubblicato anche un corso universitario: Lezioni di etica (1988).
S. Tommaso comprende Marx. La verifica non materialistica della prassi in Felice Balbo